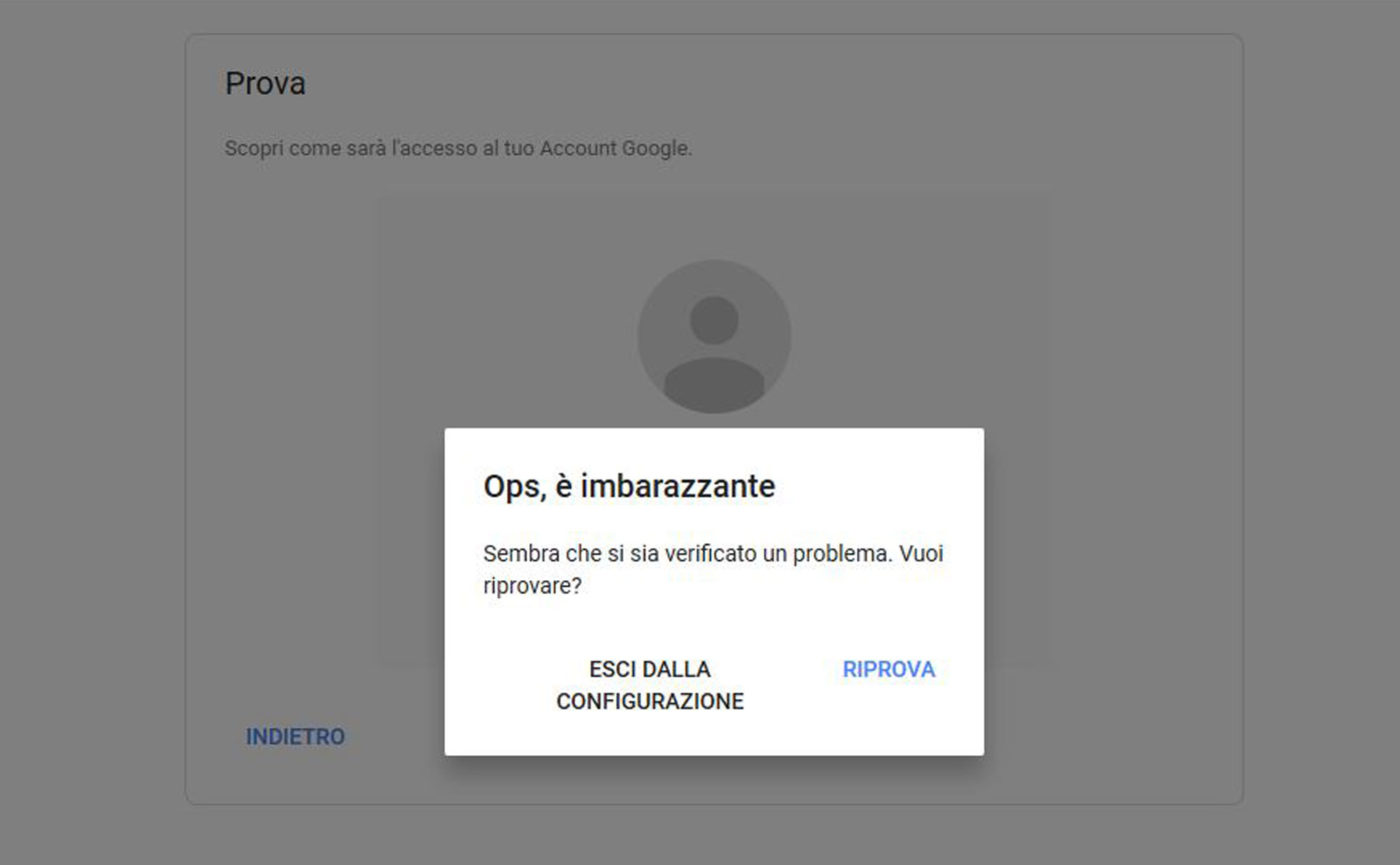Ascolto musica sin da bambino, non sono in alcun modo un tecnico della materia, i miei ascolti sono puramente dettai dall’istinto e dalla mia sensibilità. Certamente il mio modo di scoprire la musica, rispetto a un tempo, è notevolmente cambiato, appartengo a quella generazione cresciuta con i vinili, che scopriva nuove cose musicali tramite radio, riviste e acquisti casuali. Sto parlando degli anni settanta-ottanta soprattutto e parte dei novanta. Non essendosi sopita la mia voglia di ascoltare sempre nuove cose, ormai da alcuni anni, per conoscere le produzioni successive al 2000, impiego esclusivamente internet. Come detto, non sono un tecnico, ma mi pare oggi non vi sia davvero altra possibilità di scoprire cose particolari dato che, molte di esse, sono promosse e reperibili solo sulla rete, non mi capita mai di ascoltare le stesse cose in radio. Forse non me ne accorgo io, ma se così non è, significa che le radio non svolgono più la funzione diffusiva di un tempo e, che, le etichette discografiche non sono poi così attente a molte delle cose che accadono nel panorama musicale. O forse non si tratta soltanto di questo. La musica, negli anni, si è fatta sempre più fenomeno visivo e di costume, lo era già in parte negli anni Sessanta e settanta, ma con l’avvento di Music Television e degli odierni reality musicali, costume e visione sembrano aver preso totalmente il sopravvento sull’aspetto musicale, ovviamente per ragioni di marketing. E così, per ascoltare qualcosa che tenga ancora in riguardo la musica, tocca scoprirselo per proprio conto tramite internet. E, del resto, molti nuovi gruppi e compositori non hanno altra via che promuovere la loro musica in internet, liberi da imposizioni commerciali e di condurre le loro ricerche sonore.
Se mi sono abbandonato a questa lunga digressione sulla musica, è solo perché mi pare un parallelo perfetto di quanto, nei medesimi anni, è accaduto in arte. Sopravvenuti i nuovi media digitali e, con essi, il conseguente spostamento della fruizione delle produzioni artistiche, e non solo, le gallerie e i curatori d’arte si sono visti sottrarre parte del loro ruolo e larga parte dei loro ricavati economici. Alcuni di essi hanno saputo fare un uso astuto di questi nuovi media, altri invece, la gran parte, hanno replicato quella dinamica già osservata in musica. Visionando il portfolio di artisti di molte gallerie italiane, un elemento pare accomunarli – pur nella differenza delle tipologie proposte, siano esse di natura fotografica, pittorica o d’arte più orientata alle “correnti fredde” – una generale tendenza ad una produzione fortemente decorativa, carica di possibilità d’arredo. Come la musica si è fatta sempre più tappeto sonoro delle nostre esistenze, anziché fenomeno orientato all’ascolto, così, le arti visive, sono essenzialmente divenute soggetti dell’”abbellimento” interno ed esterno, casalingo o urbano, anziché elementi d’osservazione e riflessione esistenziale. Di conseguenza, i curatori, cercando anch’essi di sopravvivere, sono ormai divenuti dei mercenari pronti a proporre e sostenere qualsiasi produzione, anche quelle che ritengono aberranti, dietro adeguato compenso.
Generalmente, tutte queste produzioni propongono uno stanco classicismo, che possono assumere il sembiante di un figurativismo accademico o di sapore pop o quello di una non figurazione, che, proprio perché tale, meglio si presta allo scopo d’arredo, sia in senso formale sia cromatico e anch’esso, avendo ormai alle spalle un settantennio di produzione, si è immancabilmente mutato in classicismo, stessa cosa può ovviamente dirsi per le produzioni “fredde”. Vi sono poi le miriade d’installazioni della cosiddetta “arte pubblica”, che si esplicano e palesano in balocchi urbani caratterizzati dall’aspetto essenzialmente ludico, anziché sociale. Si, perché in questa logica, l’arte deve stupire, divertire e arredare, ma certamente non deve osare far riflettere, tornerebbe, altrimenti, ad essere elemento di “scuotimento” e sovversione sociale. È giusto, invece, che ogni cosa e ogni attore sulla scena rimanga al proprio posto, così come già dichiarava Wharol e, in tempi più recenti, sostiene Achille Bonito Oliva, fondatore e teorico della Transavanguardia e già esponente delle Neo-avanguardie che caratterizzarono, segnando profondamente, il panorama postmoderno nel nostro paese.
Ma questo mio intervento non vuole certo trasformarsi in un’esaltazione dei social media. Anch’essi, infatti, dietro un’apparente liberazione celano le medesime pratiche che, anzi, divengono ancora più stringenti e soffocanti. Liberi dunque da ogni illusione, seppure permettano a voci altrimenti inascoltate di esistere, al contempo le obliano nell’assordante frastuono dell’esorbitante mole d’informazioni che quotidianamente sono immesse e profuse e, tra le quali, naturalmente convivono con quelle stesse produzioni di natura classica e paludata. Questo aspetto, della parallela convivenza delle differenti nature produttive, non avrebbe nulla di strano o negativo, anzi la molteplicità è un carattere distintivo della sanità sociale che sa contenere le differenze. Ma il problema non è questo, il problema, semmai, è che anche queste altre produzioni che cercano di discostarsi e, in certa misura, di opporsi a quelle dinamiche, all’interno di quei canali non possono che aderire alle medesime logiche. Questo perché con l’avvento dell’Era dell’Informazione, dove la raccolta d’informazioni tramite i canali digitali costituisce il forziere economico del nuovo capitalismo fattosi immateriale, anch’esse divengono parte di una produzione alla quale vorrebbero opporsi, ricadendo, invece, nella medesima dinamica prevista dalla nuova economia dell’informazione. Ciò ovviamente accade perché le pratiche del “tempo libero” e del “divergere”, ossia dello spazio dedito al divertimento, non sono più tali. Nel momento in cui l’arte e la cultura si fanno mercato non vi è più differenza tra il tempo della produzione lavorativa e quello della “ricreazione” individuale, all’interno della quale si è consumatori e, dunque, si continua a essere parte attiva di quella dinamica economica che non lascia via di scampo, gettando le società in un’impasse disumana, proprio perché non contempla spazio per l’umano fuori delle dinamiche produttive. E, questa, non è certo una logica umana, pensata per l’umano, il quale esige un suo spazio fuori dai ruoli assegnati e imposti. L’umano è antecedente ai ruoli, alle strutturazioni sociali, l’umano è già nel venire al mondo, al di là della forma organizzativo-sociale che quel mondo si da.
Noi oggi abbiamo anteposto l’organizzazione e la struttura all’umano, sottraendole dignità d’esistenza. Ci siamo chiusi all’interno di un’astrazione strutturale, da noi stessa concepita e riprodotta e dalla quale non sappiamo sottrarci. Un’astrazione che, per sua natura, è priva di vita e, quindi, inadatta a contenerla. Questa scatola strutturale, le cui pareti immateriali erigiamo volontariamente giorno dopo giorno, ci contiene lasciando l’umano al di fuori di essa e soffocando la vita al suo interno. Non possiamo forzarne le pareti se, al contempo, le erigiamo. Gli urti e le grida provenienti da essa rimangono così inascoltate, non essendovi umanità al di fuori di essa. Questa scatola immateriale, le cui pareti sono costituite dai ruoli socio-economici sempre più di natura virtuale, è impossibile da destrutturare. O forse no. La soluzione è semplice, a portata di mano e di chiunque, proprio qui di fronte a noi, eppure in questa sua estrema semplicità è impercorribile e utopica. La cessazione da parte nostra di ogni comunicazione digitale equivarrebbe alla sottrazione della linfa economico-vitale essenziale alla sopravvivenza di questa sovrastruttura immateriale. La sottrazione del flusso d’informazioni farebbe collassare il sistema economico alimentato da esse e, a caduta, crollerebbero i ruoli che al suo interno ognuno di noi è chiamato a interpretare: cesseremmo di essere utenti e fornitori della sua materia prima e, al contempo, prodotto di essa. Priva dell’alimento, di noi, la scatola cessa, semplicemente non più “è”. Ma questa soluzione tanto semplice ed evidente è impraticabile, poiché richiederebbe una congiunzione d’intenti planetaria impossibile da mettere in atto, nel momento in cui i veicoli di comunicazione organizzativi della sua attuazione sono i medesimi obiettivi della destrutturazione, che su di essa possono vigilare, distorcere e fuorviare, sino a ricondurli alle proprie pratiche informativo-economico-politiche che l’arricchirebbe ulteriormente. Sottratta la fisicità e la geograficità, trasposte le relazioni sociali e lavorative all’interno della virtualità, l’organizzazione fuori di essa si fa inattuabile e, quella che un tempo avremmo chiamato rivoluzione, al suo interno diviene visibile e manipolabile.
Pur detto questo, come si vede, non cesso di aggredire questa impalpabile coercizione, pur se questo mio assalto può farsi inutile o addirittura rischi d’ingrassarla. Per quanto folle o vano è questo il compito che siamo chiamati oggi ad assumere, affinché chi sarà dopo di noi non si veda esistenza e futuro negati.
Per questo intervento mi è impossibile stilare una bibliografia, esso è infatti suscitato da tutto quanto ho letto e visto, dalla mia formazione e dalla mia esperienza, insomma dal sentire più intimo della mia esistenza, fatta di provenienze di differente natura che hanno portato in me le osservazioni qui riportate.